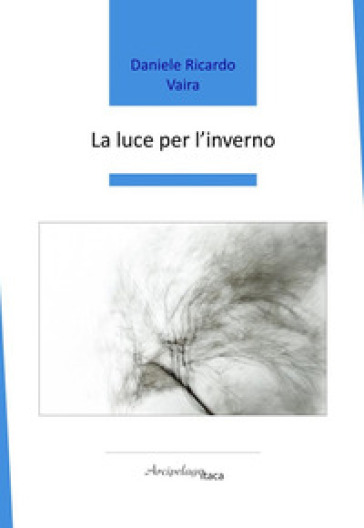Una poesia che resta accesa nel buio
Sulle tracce di La luce per l’inverno di Daniele Ricardo Vaira
C’è una poesia che non dichiara la propria potenza, ma la esercita a bassa voce. Una poesia che non si offre in pasto al lettore, ma lo invita alla soglia, lasciando intuire che varcarla comporterà conseguenze. La luce per l’inverno di Daniele Ricardo Vaira, vincitrice del Premio editoriale Arcipelago Itaca 2024, appartiene a questa genealogia: quella del poco, del raccolto, dello scarto significativo. La sua è una scrittura che non impone significato, ma lo cerca con pazienza e incertezza, come se ogni parola andasse ascoltata prima ancora che compresa.
Uno degli elementi più distintivi della raccolta è il modo in cui lavora sul tempo. Non tanto come cronologia o narrazione, quanto come condizione percettiva. Vaira non scrive da un presente pieno, ma da una soglia in cui il tempo è sospeso, rarefatto, a tratti svuotato di direzione. Si avverte, in questo, un legame sotterraneo con la tensione dei romanzi di Jon Fosse, con i silenzi dilatati di Andrej Tarkovskij, dove la scansione temporale cede il passo a un’attesa, a una durata quasi metafisica. Ogni parola sembra messa in discussione dalla successiva, e in questo equilibrio instabile si genera una forma di verità non definitiva, ma autentica.
Le immagini, più che costruite, affiorano. La poesia di Vaira ha qualcosa di cinematografico, ma non nel senso dello spettacolo: piuttosto, nella modalità del montaggio emotivo, simile a quello sperimentato da registi come Chantal Akerman o scrittori come Raymond Carver. Si procede per accostamenti, per ellissi, per sospensioni. Non c’è linearità, ma una logica interna alle immagini che costruisce senso per evocazione più che per argomentazione.
Il linguaggio è preciso, privo di compiacimento. Le parole sembrano scelte con l’attenzione artigianale di chi sa che ogni suono, ogni pausa ha un peso. Il lessico è quotidiano ma mai dimesso, sobrio ma non povero. In certi passaggi si avverte un’eco della Mariangela Gualtieri più terrena, spogliata però della dimensione rituale. Qui tutto resta umano, prossimo, fragile. La poesia ha odore di muro, suono di serranda, materia di stoviglie.
Decisiva è anche la costruzione della relazione: con gli altri, con la madre, con l’amore, con la città. Le figure care non sono mai celebrate, ma nominate con pudore. Appaiono in filigrana, come presenze che sfumano, che bisbigliano. In questo, Vaira sembra avvicinarsi a certe scritture intime e non lineari di Annie Ernaux, o alla voce rarefatta e interrogativa di Jacqueline Risset. La relazione, qui, è sempre un evento minimo ma determinante.
La luce per l’inverno è un libro che rifiuta la chiusura. Nessuna poesia cerca di “chiudere il cerchio”, ma tutte indicano una direzione. È una raccolta che chiede al lettore di ascoltare senza fretta, di entrare in punta di piedi, accettando di restare nell’incertezza. Non c’è una morale, ma una postura: quella di chi non si sottrae alla complessità, di chi abita la soglia tra dolore e meraviglia.
Alla fine, non resta una tesi. Resta una presenza. Una voce che conosce la caduta ma non la spettacolarizza. Una voce che, come suggeriva Paul Celan, “impara a stare al mondo / con parole più piccole”
Bia Cusumano