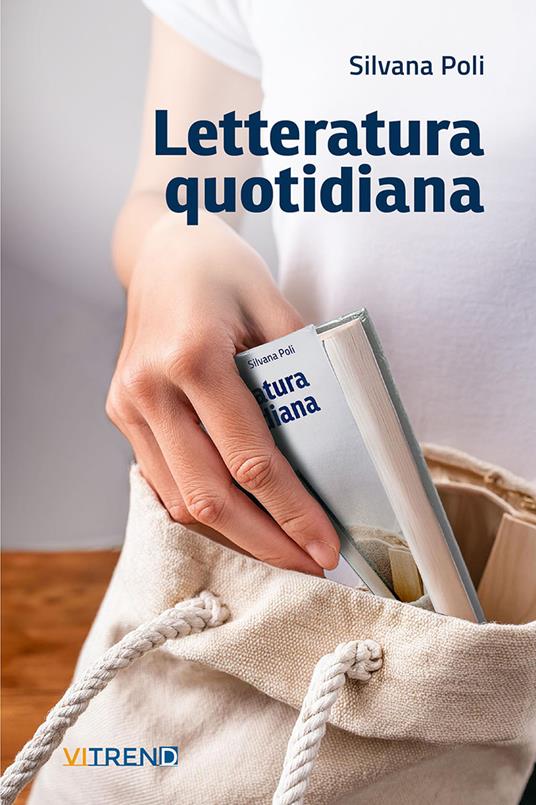Letteratura Quotidiana di Silvana Poli – recensione
Nel numero pubblicato a metà ottobre, ho già avuto modo di parlare della professoressa Silvana Poli (qualcuno magari ricorderà che l’ho definita insegnante di LetteraCura), e se torno a parlare di lei è perché, in quella occasione, scrissi che era appena uscito il suo nuovo libro e che avrei avuto il piacere di leggerlo. Bene. L’ho fatto, e l’autrice non poteva che conquistarmi una seconda volta.
Il nuovo libro, dal titolo Letteratura quotidiana, ha, come il precedente, lo scopo di avvicinare il lettore, anche il più pigro o chi non ha fatto studi umanistici, alla grande letteratura, rendendola semplice, chiara e soprattutto: utile.
Divulgatrice letteraria, come lei stessa si definisce, è molto attiva su YouTube, dove pubblica, per l’appunto, contenuti di grande interesse sui classici. Con chiarezza e passione, ne illustra le trame e il significato profondo, rendendoli accessibili perfino a chi, ai tempi della scuola, li aveva detestati. Con sorprendente abilità, si addentra nei versi di poeti e narratori, riuscendo a renderli vividi e coinvolgenti. Anche in questo nuovo testo, l’impostazione cattura subito l’attenzione del lettore.
Dopo il libro Letteratura passe-partout, in cui mostrava come i grandi classici possano offrire risposte ai nostri problemi, la Poli ci propone ora un nuovo viaggio, approfondendo la realtà storica e il pensiero di alcuni tra i più grandi autori. Da Francesco d’Assisi a Ungaretti, da Dante a Grazia Deledda, passando per Petrarca, Boccaccio, Foscolo, Leopardi e altri, l’autrice costruisce un percorso chiaro e appassionante.
Ogni capitolo segue un’impostazione precisa: contesto storico, cenni biografici, bibliografia dell’autore, parafrasi dei testi più significativi affiancata al testo originale e una sintesi che ne riassume il pensiero essenziale. Questa impostazione offre una panoramica esaustiva che invoglia alla lettura.
Dall’introduzione estrapoliamo: “L’idea di questo libro è nata proprio dal pensiero che alcuni scritti, che popolano le antologie scolastiche, abbiano qualcosa da dire anche al di fuori delle aule e al di là delle cattedre.”
È questo il progetto che la Poli porta avanti con determinazione: diffondere il più possibile la conoscenza di testi che ci accompagnano da secoli al fine di conoscere noi stessi.
Da pag. 32: “Nel Purgatorio, Dante descrive sette atteggiamenti velenosi in cui cade l’uomo e presenta anche i sette antidoti: tra i depositari di tali rimedi troviamo l’Angelo dell’Umiltà, custode della cornice in cui i superbi espiano i loro peccati. Il termine ‘superbia’, invece, deriva da super, che significa ‘sopra’, e bios, che indica la forza, oppure dal sanscrito bhos, radice da cui deriva il verbo ‘essere’. Il termine, quindi, indica una forza che si pone al di sopra, lontana dalla terra. Cosa vediamo quando ci poniamo in basso? Facciamo come i bambini e, per un attimo, sediamoci a terra. Da lì il nostro mondo cambia: nella prospettiva dei piccoli, ognuno, guardando in alto, può notare la grandezza dell’altro. Questa visione, che è consueta per l’infanzia, può essere molto preziosa nella relazione di coppia: se entrambi sanno vedere la grandezza dell’altro, accrescono sia la considerazione che il rispetto reciproco, e questa consapevolezza aiuta ad assumere un atteggiamento misurato e non arrogante. In tal modo, ambedue si sentiranno accolti e riconosciuti per quello che sono. Dante quindi ci propone di essere umili per coltivare l’amore e per costruire, ogni giorno, una storia di vita assieme. E, se ci riflettiamo, l’umiltà può essere un atteggiamento spendibile anche in altri ambiti della vita in cui vogliamo coltivare altre relazioni preziose.”
E ancora da pag. 39: “Francesco Petrarca racconta di aver incontrato Laura il Venerdì Santo, 6 aprile del 1327, nella chiesa di Santa Chiara ad Avignone, durante la celebrazione della Passione di Cristo. Consultando il calendario di quell’anno, scopriamo però che il 6 (numero spesso utilizzato da Petrarca nei suoi scritti) aprile era un lunedì e, se vogliamo cercare altre informazioni sulla bella Laura, siamo destinati a restare delusi: di lei non abbiamo altre notizie biografiche che quelle fornite dal poeta. Qualcuno avanza l’ipotesi che questa donna non sia quindi mai realmente esistita. Del resto, se ci fermiamo a riflettere sul suo nome, possiamo ricordare che esso richiama la pianta con cui vengono incoronati i poeti, il lauro o alloro. Petrarca non ha paura di far sapere al mondo quanto lui ambisca a ottenere l’alloro poetico, prestigioso riconoscimento assegnato ai maggiori poeti. L’alloro poi si collega al mito di Dafne, la ninfa amata da Apollo, che viene trasformata in una pianta di alloro per sfuggire alle grinfie del dio di tutte le arti, e quindi anche della poesia. Tali miti sono conosciuti da Petrarca, che potrebbe aver utilizzato il nome Laura per raccontare le diverse dimensioni della sua passione: l’amore per una donna unito alla passione per la poesia e per la gloria che ne deriva.”
Non so se qualche letterato potrà ritenere il testo “sbrigativo” o “insufficiente”, dato che si tratta di capolavori sui quali sono stati scritti decine e decine di libri, ma ho estratto questi paragrafi per darvi un’idea di come l’autrice riesca ad approfondire l’argomento, stimolando la curiosità del lettore.
Di Pirandello, ad esempio, La Poli evidenzia come, da una riflessione (lo scrittore osservava una donna anziana vistosamente agghindata) avesse maturato il “sentimento del contrario”, mentre, con la novella dal titolo La patente, ci fa scoprire come trasformare “la sventura in un vantaggio”.
Di Grazia Deledda, analizza il “valore del perdono”. Ed è così che, pagina dopo pagina, il lettore, attraverso la vita e le opere degli autori, riesce a cogliere pienamente il pensiero e la sua origine.
Per tutto questo, oggi mi piace definire la professoressa Poli “guida del turismo letterario”. Sì, parlo di “turismo” perché, leggendo il suo libro, mi sono paragonata a quel viaggiatore che va a visitare un capolavoro artistico (una cattedrale, un museo…) senza essere uno storico, un architetto o uno scultore, e grazie a una guida preparata, riesce a comprendere e apprezzare tutta la bellezza di quell’opera d’arte.
Adelaide J. Pellitteri