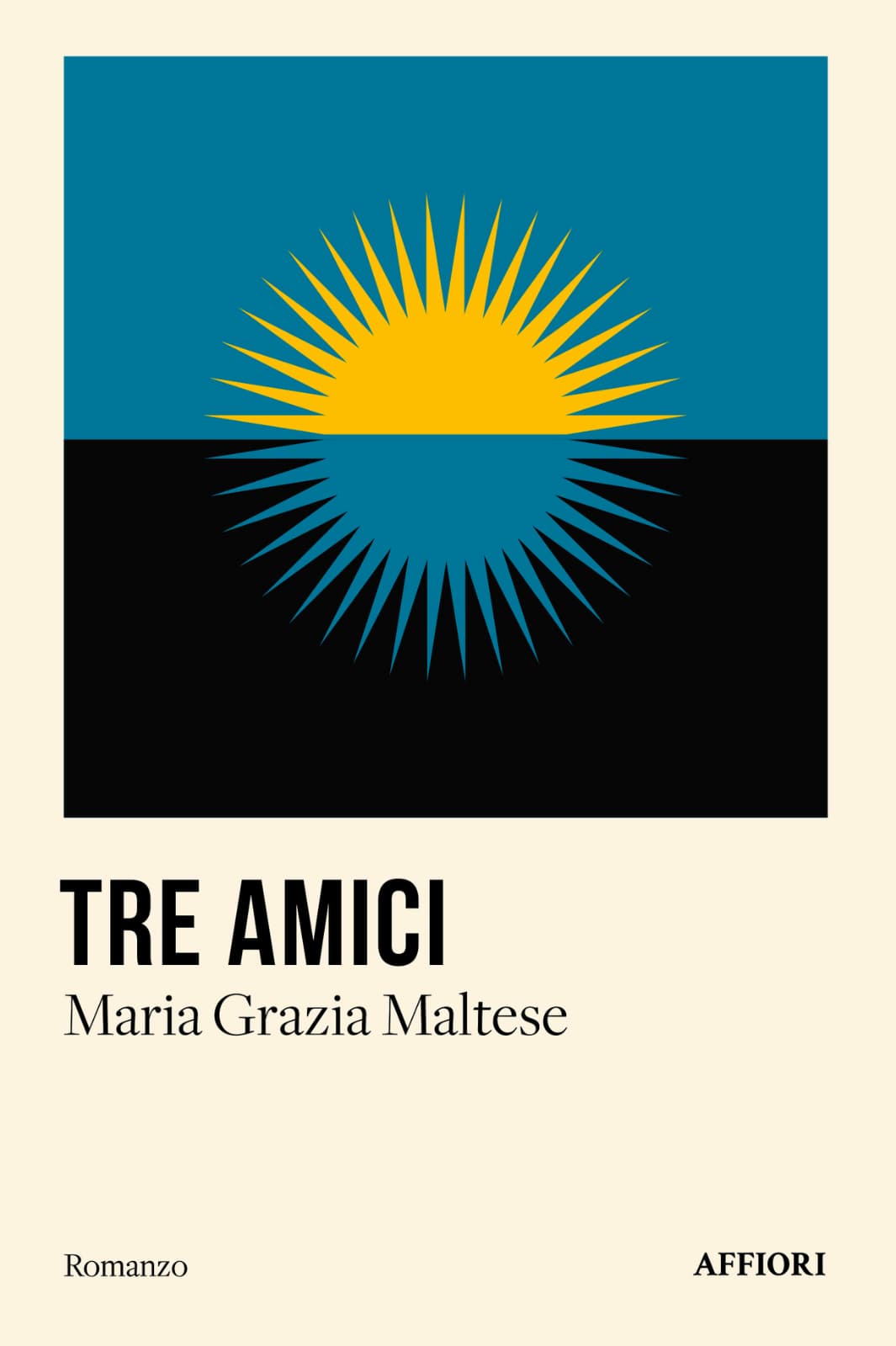“Tre Amici” Un romanzo di amicizia e di ideali
Federico, Maria e Gaspare sono tre inseparabili amici, vivono in un regime repressivo, soffocante. Un governo nemico si è insediato facendosi garante delle ingiustizie. I tre amici sentono che quegli ideali per i quali hanno sempre lottato sono calpestati, offesi, traditi. Il loro impegno di giovani paladini della giustizia, è lottare contro un potere criminale, nel tentativo di sconfiggerlo, annientarlo. Uniti, contro Cesare, il nome in codice di chi gestisce il potere, affronteranno ogni pericolo per salvare i loro sogni di libertà e giustizia. Non possono spegnere la loro idea di un mondo giusto, hanno bisogno di uccidere la debolezza degli uomini e farla risplendere nella forma del tentativo eroico di fare qualcosa di più. È l’idea di Gaspare, il contestatore, convinto che se si muore “ciò che è giusto non muore”. Una sfida difficile che unirà i tre nel sogno utopico di voler cambiare il mondo.
L’attivismo politico e l’amicizia sono al cuore della trama. C’è un episodio specifico o una riflessione personale che ha ispirato questa storia?
L’idea nasce da una riscrittura teatrale, cioè l’idea di riproporre una versione di Giulio Cesare di Shakespeare, trasformando Bruto e Cassio in giovani sessantottini. Due personaggi storici reinterpretati e catapultati in un altro periodo storico. Un’occasione in qualche modo per parlare di continuità storica, quella delle giovani generazioni che lottano per il cambiamento, per la democrazia. Nel momento in cui “Tre amici” è diventato un romanzo, ho pensato che forse era sbagliato parlare di un passato lontano. La strada da seguire allora era provare a pensare che cosa avrei fatto io, che cosa avremmo fatto noi nei confronti di un potere autoritario, quindi ho spostato il periodo storico in un futuro più o meno prossimo. Devo aggiungere che questa idea si completa, indubbiamente, con l’esperienza diretta di spazi occupati; e soprattutto, direi, la conoscenza di quasi vent’anni di lavoro autonomo, associazionismo sociale che lavora nei quartieri. Queste esperienze mi hanno permesso di capire che ci sono diversi modi di intendere l’attivismo e la partecipazione.
Federico, Maria e Gaspare affrontano dilemmi morali complessi. In che modo sei riuscita a dare voce ai loro dubbi e alle loro fragilità?
Non è facile dire se sono riuscita a farlo bene, ho tentato. Se devo rispondere con sincerità, direi che probabilmente in qualche modo Federico risponde ai miei dubbi, alle mie perplessità, alle mie assenze di risposte chiare. La parte di me che cerca. Gaspare invece mi rappresenta in parte in quello che vorrei essere. Mi spiego meglio, la decisione le idee chiare, l’essere attivi ed il volersi muovere che in parte stimo ed in parte non sopporto.
I tre protagonisti possono essere considerati personaggi contemporanei in cui i giovani di oggi possono rispecchiarsi?
Sì e no, non lo so. Una cosa che pensavo è che in qualche modo l’idea nasce da un filo conduttore, da una costante: l’attivismo, la protesta, l’ammazzare anche metaforicamente il potere per cambiare le cose. Ed in qualche modo, io ho sempre pensato che c’è un percorso di miglioramento regolare nella storia. Dico dagli schiavi dell’antico Egitto, alle lotte operaie sessantottine, al welfare dei giorni nostri c’è un costante miglioramento. Non sono sicura se noi stiamo vivendo questo. Ma a proposito del Sessantotto voglio dire che gli operai della Fiat vivevano un rilevante divario economico tra loro ed Agnelli e se proviamo a quantificarlo con quello che accade oggi, tra l’amministratore delegatodi Amazon o della stessa Fiat e la paga di un operaio, questa forbice si è allargata enormemente. Mi chiedo che cosa sia successo. Forse i giovani, non so, non contestano più o si limitano a sfotterci?
Oggi nell’era dei social, dell’intelligenza artificiale c’è ancora spazio per i grandi ideali, per le grandi imprese?
Io umilmente, senza avere le risposte, dico sì. I grandi ideali li ritrovo per lo più in quella che è la tematica ambientalista. Le grandi battaglie dei ragazzi, dei giovani attivisti riguardano la sostenibilità ambientale, il cambiamento climatico, il futuro del pianeta. Le loro lotte non le trovo più in quelle della giustizia sociale. Temo a tratti che quel contrasto del giovane che contesta il vecchio, sia diventato più uno sfottò, un prendere in giro. Ci sono tanti video in cui le nuove generazioni canzonano le vecchie, ma quella sana e sacrosanta contestazione, quella rabbia la ritrovo sui temi ambientali, questo è fondamentale, ma sento la mancanza della contestazione sociale.
Il tuo romanzo parla di amicizia in contesti estremi. Che ruolo pensi che abbia l’amicizia oggi dove spesso l’amico con cui dialogavamo in presenza è stato filtrato da uno schermo digitale?
Io ho amiche dalla prima elementare, ho questa fortuna e forse per questo ho speranza che l’amicizia continui a vivere la realtà. L’amicizia è una cosa fondamentale che accomuna i ragazzi di oggi come quelli di ieri. È un legame forte, vivo che si costruisce nei rapporti reali attraverso il dialogo, il confronto, ponendo attenzione all’altro, prendendosene cura. Nel mio romanzo è l’amicizia che dà forza e coraggio ai tre amici nell’aiutarsi, nel confrontare i propri sogni, i propri ideali ed è questo che li fa crescere. Il virtuale non costruisce stima ed affetti reali.
Federico, Maria e Gaspare tra incertezze ed emozioni affrontano un bivio cruciale: la scelta di agire attraverso un attentato. L’amicizia li porterà a sfidare la realtà, mentre con lo sguardo alle stelle difenderanno coraggiosamente i loro sogni ed i loro ideali giovanili. Tre protagonisti che rappresentano luce e speranza in un mondo dominato dall’oscurità politica, dalla prepotenza, dall’ingiustizia. Ma fino a che punto si può restare fedeli a sé stessi? E quanto costa trasformare un’idea in azione, un sogno in realtà?
Marisa Di Simone